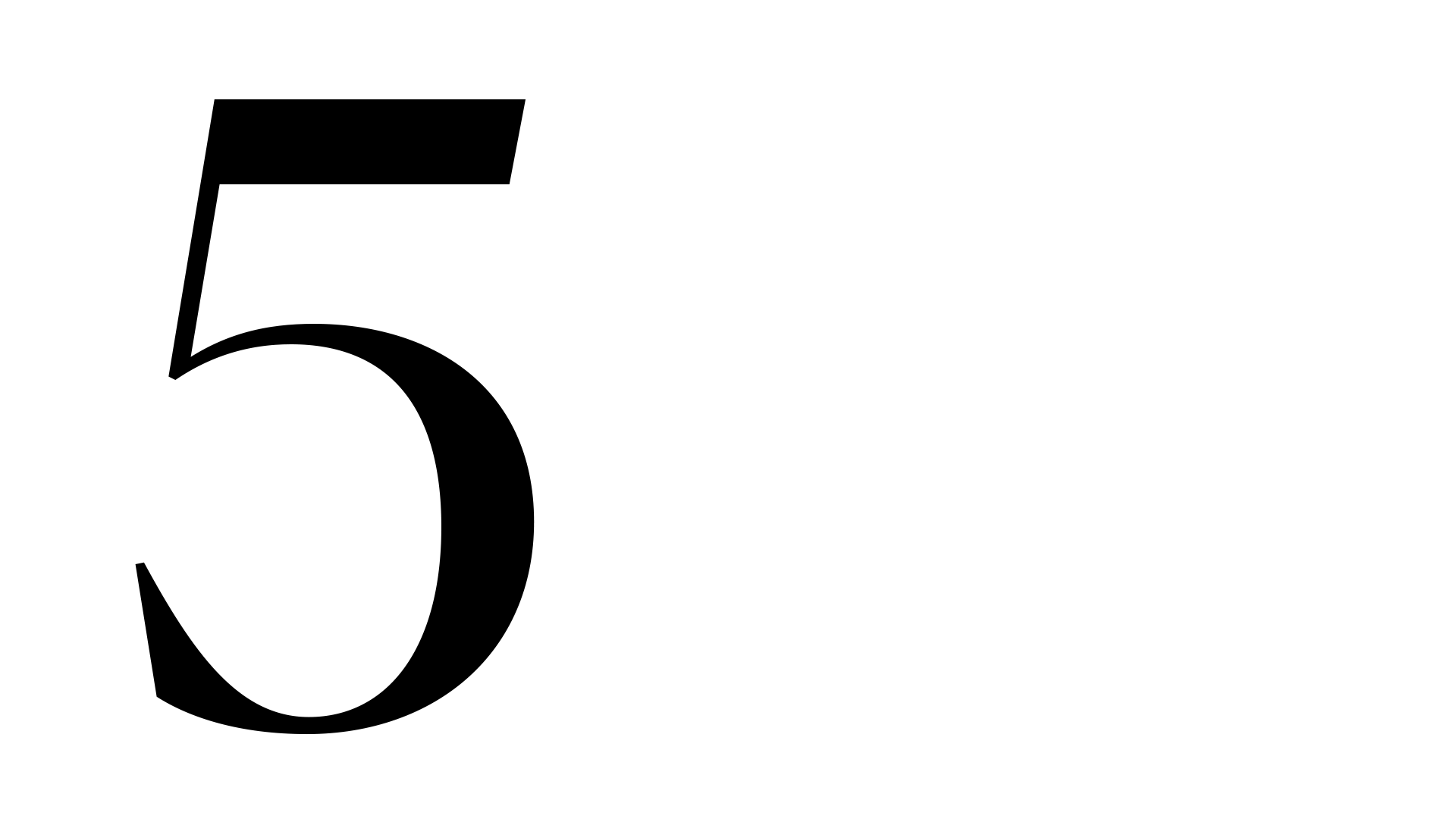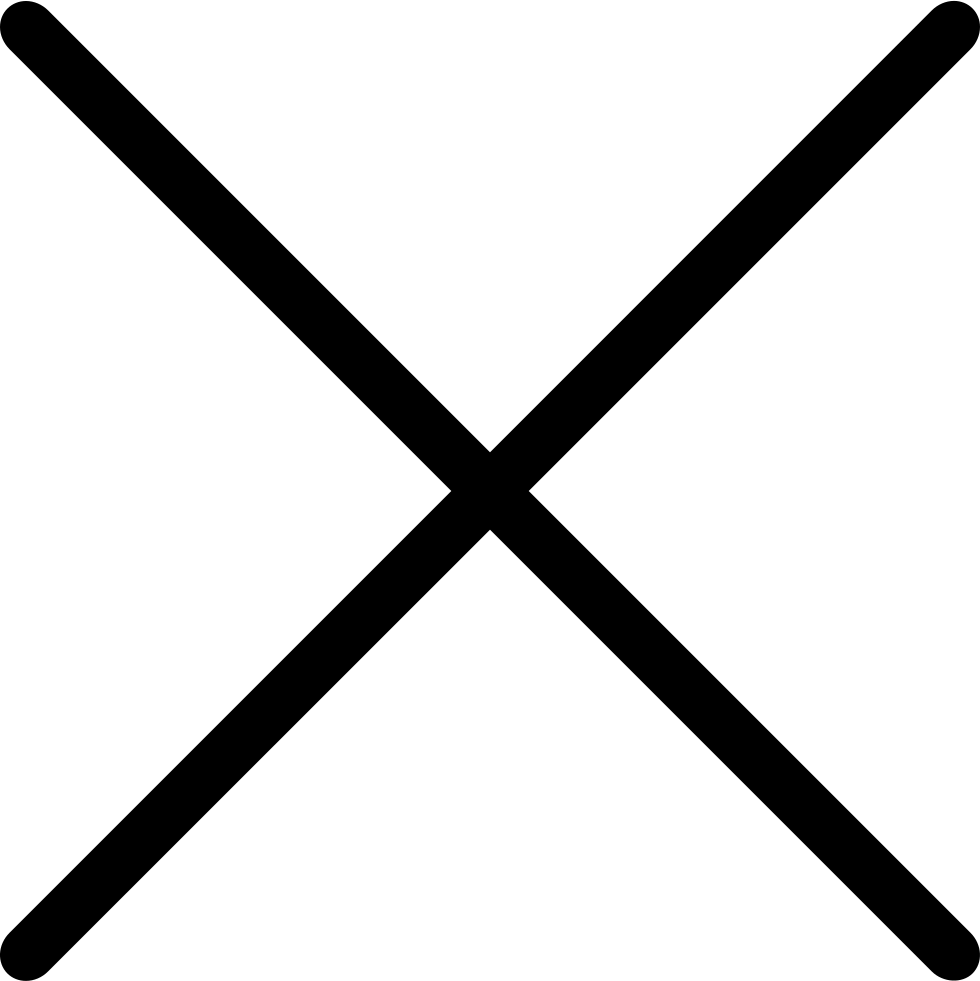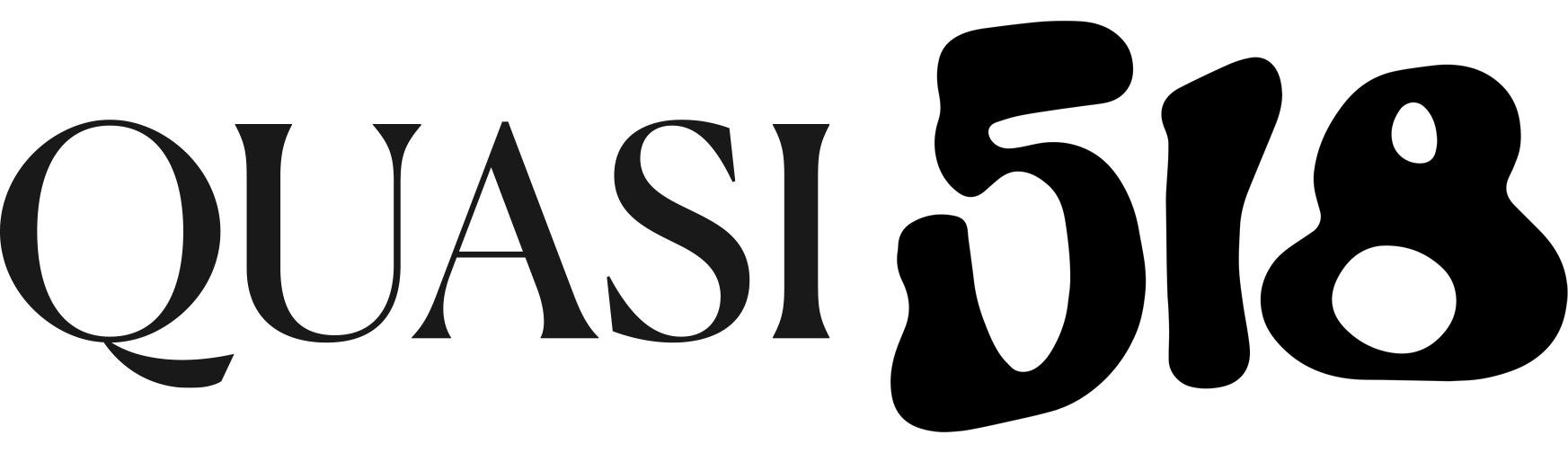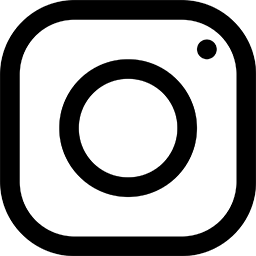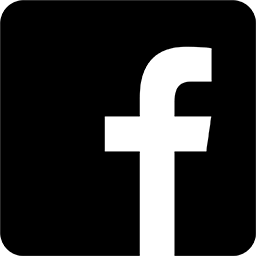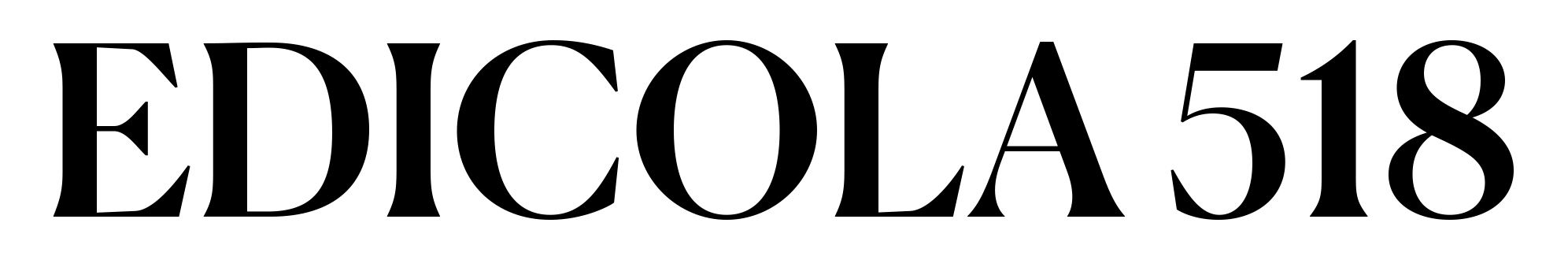La premessa dell’Impero della Neomemoria sembra lo sconcertante trucco di un prestigiatore: la biografia di un poeta si trasforma nell’autopsia di un impero. Ma la verità è che non c’è nessun trucco. L’ammaliante illusionismo di una prosa ipnotica non nasconde niente se non un raro rigore analitico, capace di rinvenire nei casi di una vita umana i segni profondi dello psico-imperialismo occidentale. Di una civiltà che ossida tutto ciò che tocca e ne incorpora i frammenti in un sistema di controllo della memoria. Heriberto Yépez, saggista e poeta messicano, conduce una spietata vivisezione della vita e l’opera di Charles Olson, «pioniere del postmoderno», per diagnosticare le ossessioni di una civiltà in declino: la ri-mitizzazione orientalista delle culture indigene; l’oppressione psico-sociale del patriarcato; la vacuità terminale di una neomemoria che degrada la profondità del simbolo alla vendibilità del kitsch.
Decretando «la fine della teoria critica», a causa della «sua nord-americanite», Yépez inaugura una nuova forma di ricerca, con cui, fra inventiva surrealista, vivacità lirica e chirurgiche stoccate antioccidentali, riesce a disegnare una vivida psico-cartografia dell’impero. In queste pagine, una brillante rilettura del mito/complesso di Edipo porta alla teoria maya dello spazio-tempo; Philip Dick ed Ezra Pound incontrano il serpente piumato Quetzalcoatl e la mitologia mesoamericana segna la crisi dell’idea stessa di «terzo mondo». Così Yépez riesce in un’impresa titanica: denunciare la «volontà di coerenza» di un imperialismo morente da una prospettiva subalterna e marginalizzata, per rompere l’incantesimo colonialista e farci intravvedere, anche solo per un istante, la potenza immaginifica di un cosmo multiforme in cui «il caos è la prova ultima dell’esistenza della libertà».